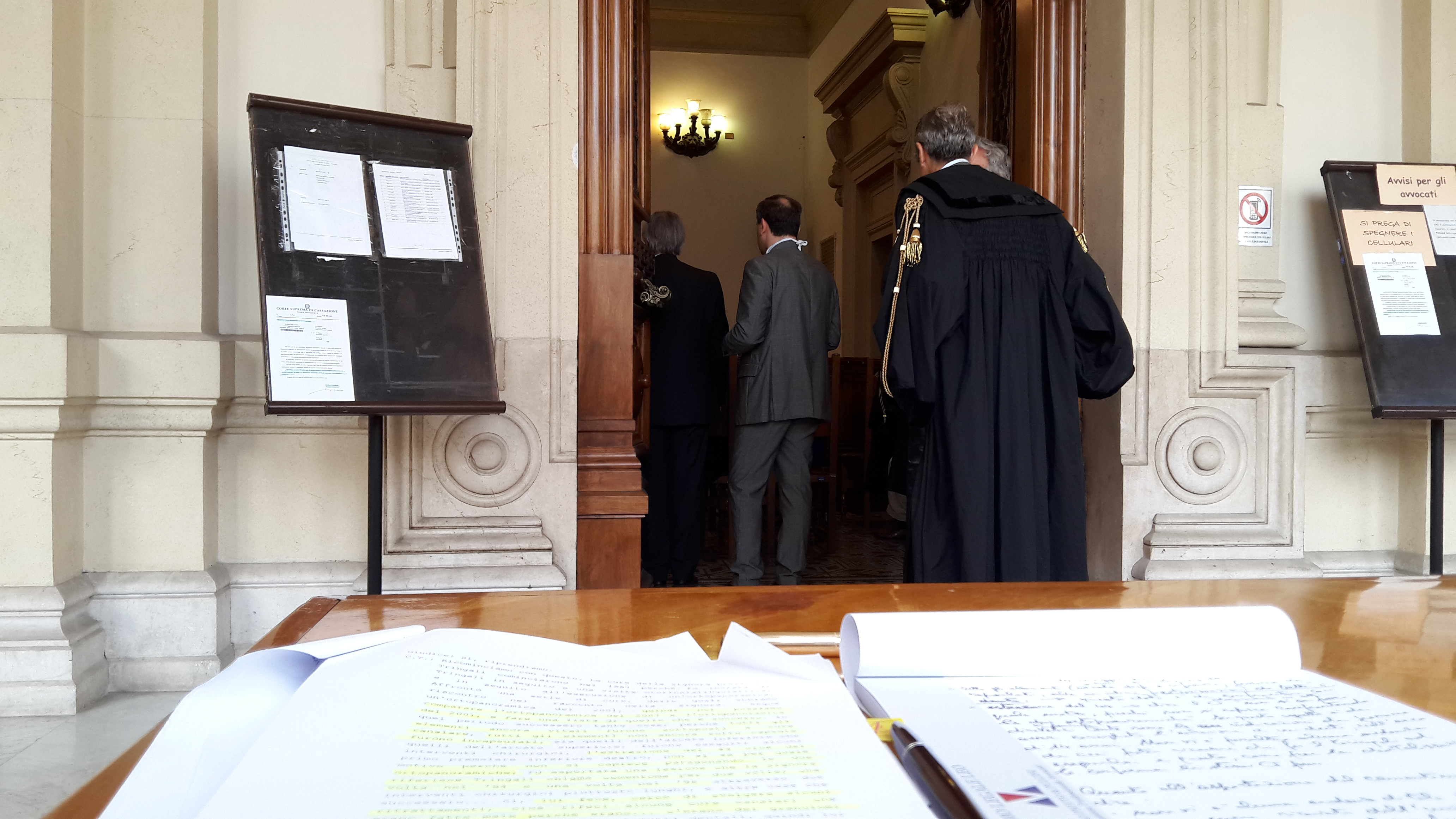Quando l’obiettivo della difesa è quello di ottenere la svincolo delle somme sequestrate sui conti dell’imputato, puntare sulla prescrizione rischia di essere una strategia processuale inutile.
La linea evolutiva della nostra giurisprudenza penale è, infatti, quella di erodere progressivamente la portata pratica di un istituto da sempre avversato dai giudici: la prescrizione del reato.
Questo è l’approdo della recentissima SS.UU. depositata il 21 luglio 2015, la quale aggiunge una seconda statuizione, di non minore importanza: quando ci si riferisce a denaro giacente su rapporti intestati all’imputato, si può procedere al sequestro e alla confisca in modo diretto, fino all’ammontare del prezzo o del profitto del reato, senza dover prima verificare che tali somme siano proprio quelle provenienti dal delitto. Tutto ciò è reso possibile dalla natura del denaro, bene fungibile per eccellenza.
Quanto alla prima questione, è da dire che la Corte ha potuto superare lo sbarramento della prescrizione richiamando la natura della confisca del prezzo o profitto del reato.
Si tratta della cosiddetta confisca diretta, la quale si distingue da quella per equivalente in ragione del fatto che la seconda – che si rende possibile quando, non potendosi realizzare la prima, si vanno a sequestrare beni nella disponibilità del reo, anche se non direttamente riconducibili al reato – ha natura sanzionatoria. La natura della prima, invece, è correlata alla sua funzione, che è quella di sottrarre all’imputato un bene che, per la sua stretta derivazione dal delitto, è entrato nel suo patrimonio quale effetto di un negozio con causa illecita. In questo caso, perciò, la confisca non integra una pena patrimoniale ma si limita ad annullare un’ acquisizione civilisticamente priva di causa.
Una simile ricostruzione, nel ragionamento dei giudici, permette di superare le obiezioni sollevate dalla Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU), secondo la quale, al di là delle etichette giustapposte dal singolo Stato, ciò che conta per verificare se una certa misura appartiene al genus della pena (a contenuto patrimoniale), è la sua sostanza. Se essa comporta non già l’eliminazione di un vantaggio indebito (scopo riparatorio/preventivo) ma l’ablazione di un parte di patrimonio che non sia legata da un nesso di derivazione causale col singolo fatto oggetto del giudizio (scopo punitivo/deterrente), siamo allora nel campo delle pene e, per la sua applicazione, si richiede un accertamento definitivo della responsabilità del soggetto agente secondo i canoni del giusto processo.
Quando, viceversa, la natura della confisca non sia sanzionatoria, è possibile valorizzare l’accertamento giurisdizionale svolto, anche se non culminato nel giudicato formale.
Il termine di paragone più prossimo è quello dell’azione civile di danno inserita nel processo penale: anch’essa rimane valida in caso di prescrizione del reato a patto che vi sia stata quantomeno una sentenza di condanna in primo grado.
Perché la confisca diretta possa sopravvivere alla prescrizione è dunque necessario che ci sia un accertamento completo del fatto e della responsabilità del suo autore, anche se non passato in giudicato. Tale accertamento può essere quello di un primo grado di giudizio ma anche quello, purché esaustivo, compiuto in una fase processuale diversa. In particolare, l’obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non assorbe quello di pronunciarsi sulla sussistenza degli estremi della confisca in parola.
In conclusione, è possibile confiscare in via definitiva il prezzo o il profitto del reato, anche se, nel corso del processo, sia intervenuta declaratoria di prescrizione. Non è invece possibile farlo se si tratta di sequestro per equivalente.
Con l’aggiunta che, sempre secondo la sentenza in commento, non si tratterà mai di confisca per equivalente, vertendosi sempre in ipotesi di confisca diretta, quando la misura colpisca somme di denaro depositate a nome dell’imputato.
E sarà confisca diretta tanto nel caso di prezzo che di profitto , e, con riferimento a quest’ultimo, sia che il profitto consista in un effettivo accrescimento patrimoniale, sia che rappresenti un risparmio di spesa.
La più importante conseguenza di questo inquadramento è che l’ablazione della somma non è subordinata alla verifica che la stessa provenga direttamente dal delitto per cui si procede, in quanto la particolare natura fungibile del bene-denaro, rende inesigibile la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato. Saranno sequestrabili e confiscabili le somme giacenti su rapporti di pertinenza del reo fino alla concorrenza dell’importo pari al prezzo o profitto di quel reato.
Il che comporta un’indubbia semplificazione, vale a dire l’enucleazione di una confisca di denaro che si comporta come quella per equivalente, quando si tratta di escludere la necessità dell’accertamento di una diretta derivazione delle somme dal reato, e come quella diretta quando si tratta di farla sopravvivere alla prescrizione.
Facile ipotizzare che ben pochi imputati lasceranno somme sui propri conti.
Autore dell’articolo: Enrico Leo. Tutti i diritti riservati.